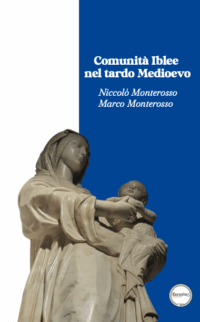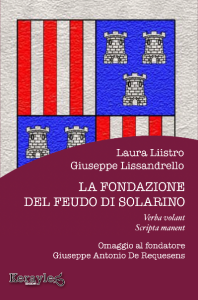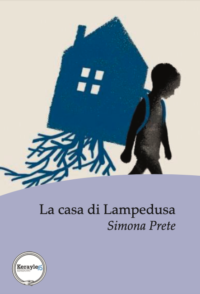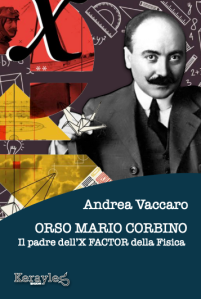Descrizione
Tra Quattro e Cinquecento, sulla base di un nuovo rapporto vassallatico, favorito anche dal ridimensionamento del ceto baronale voluto da Ferdinando il Cattolico e Carlo V, le comunità iblee sviluppano una forte impronta “municipalistica”. L’arbitrio e le prevaricazioni dei baroni non sono più accolti con rassegnazione, la formazione di un ceto proto-imprenditoriale, determinando l’alterarsi dei rapporti di produzione, tende a ridefinire i rapporti politici tra governanti e governati. L’emersione dagli atti di un ceto di “benestanti o facoltosi” – non solo grandi affittuari di terre o mercanti ma anche appaltatori di gabelle, medici, sacerdoti e notai – segna l’affermazione di un “ceto di mezzo” che ritroviamo, sempre più spesso, a capo di quel partito che entra in conflitto con il potere baronale per il controllo delle amministrazioni locali. È quello stesso ceto che promuoverà il riscatto dei feudi al demanio regio e che, spregiativamente indicato dai feudatari come “consorteria”, non temerà di contrapporsi agli ufficiali cittadini e agli stessi baroni.